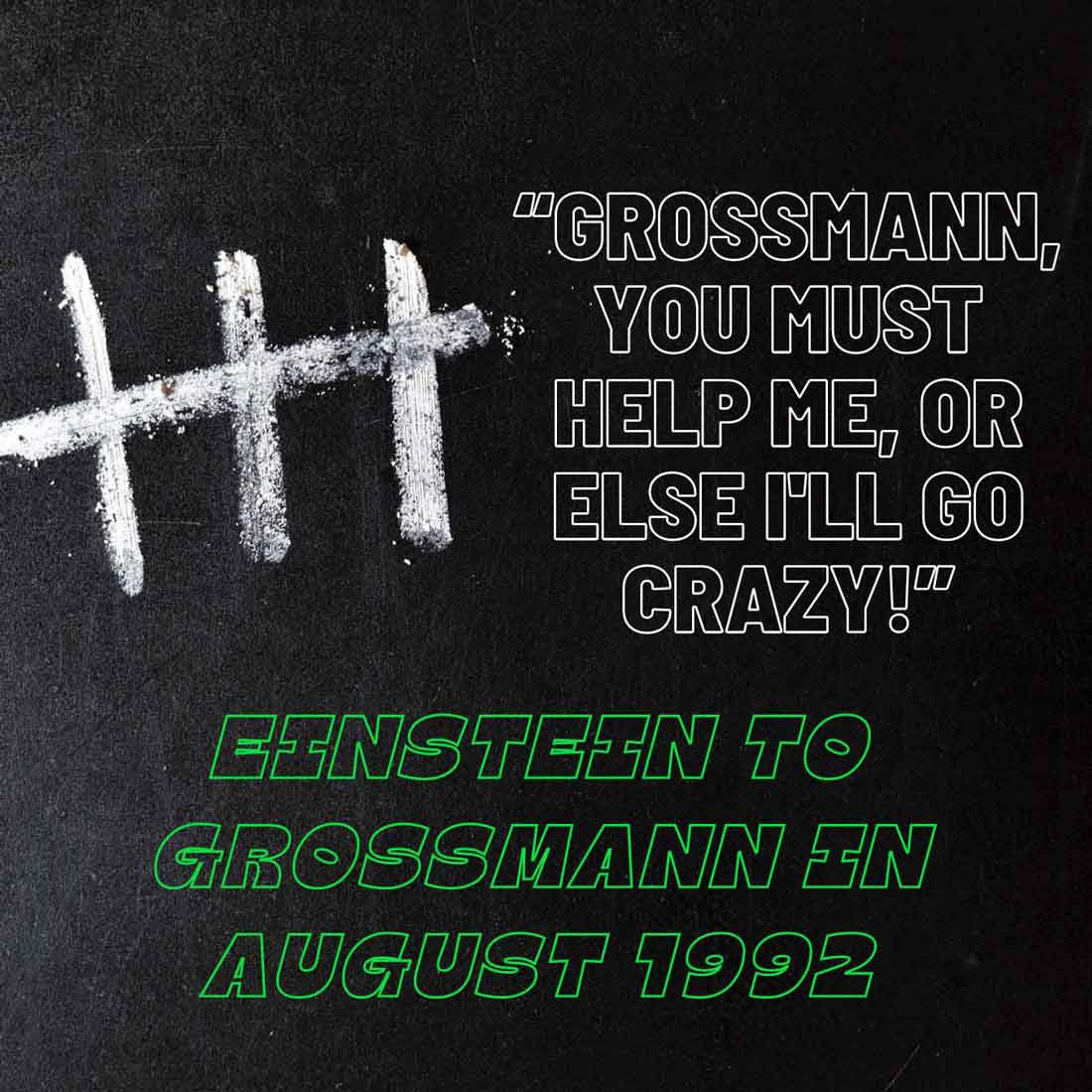Questo articolo è il sesto “episodio” di una serie dedicata alla figura di Einstein e agli anni compresi tra la nascita della relatività speciale e generale, anni fondamentali per la scienza e la filosofia del ventesimo secolo (e non solo).
Ricapitoliamo, siamo nel 1912. Einstein ha capito che la gravità è accelerazione, che la gravità piega la luce e rallenta gli orologi, che c’entrano le geometrie non-euclidee.
Einstein ha alcuni principi guida: 1. devono valere le leggi di conservazione della fisica classica; 2. nel caso in cui la gravitazione è bassa si deve tornare al caso classico; 3. le leggi che cerca devono valere anche nei sistemi di riferimento accelerati.
L’amico matematico Grossmann gli dice che due matematici italiani (Ricci Curbastro e Levi-Civita) hanno sviluppato un calcolo, che oggi chiamiamo “calcolo tensoriale”, che è proprio ciò di cui ha bisogno.
Einstein lo impara e capisce che il cosiddetto “tensore di Riemann” è molto importante. I tensori sono insiemi di numeri organizzati che se applicati a un vettore danno un numero. A ogni punto dello spazio tempo possiamo ascrivere una di queste tavole di numeri. Inoltre questi numeri quando cambiamo sistema di coordinate devono trasformarsi in base a precise regole. Il tensore di Riemann misura la curvatura dello spazio in un punto. E può essere contratto, cioè semplificato, dando il tensore di Ricci, che misura come si calcola il volume in un punto, oppure addirittura si può ottenere anche un solo numero, cioè lo scalare di Riemann.
Sono tutti strumenti nelle mani di Einstein e Grossmann, che nel ’13 pubblicano il cosiddetto “Entwurf”, abbozzo, che assomiglia molto alla teoria che poi nel ’15 si imporrà come quella corretta, ma resta il problema che i due non sono capaci di riprodurre il caso classico quando la gravità è bassa. Qualcosa non va.
Siamo vicini: le equazioni di Einstein sono 10, da un lato c’è il cosiddetto “tensore energia-impulso”, che descrive la distribuzione della materia e dell’energia, dall’altra la geometria dello spaziotempo. Vedremo come va a finire nelle prossime puntate.
Potete trovare il primo articolo di questa serie qui.
Vincenzo Fano è docente ordinario di Logica e Filosofia della Scienza presso il corso di laurea magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teorie e Gestione della Conoscenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo.